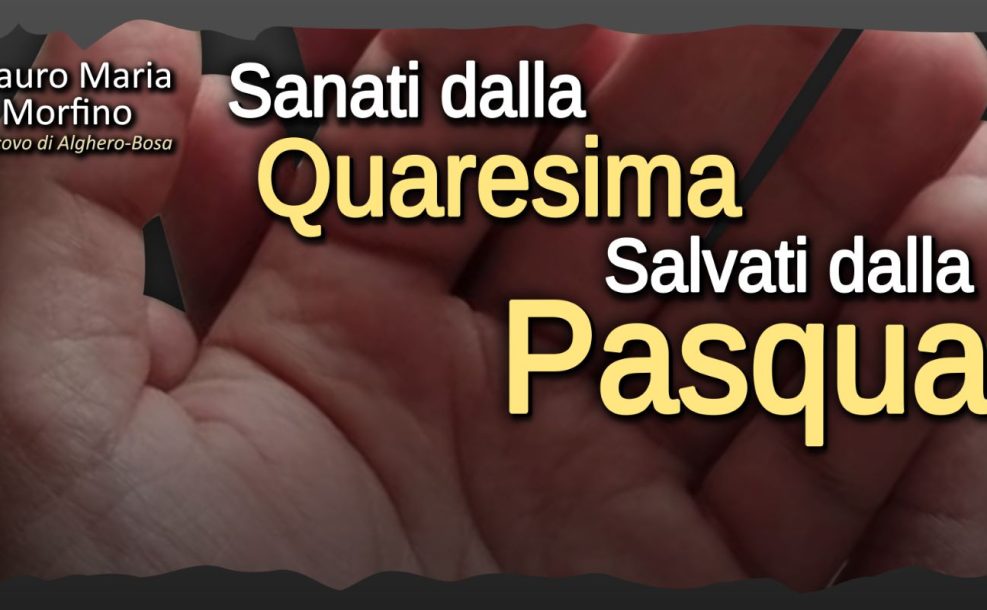Sanati dalla Quaresima. Salvati dalla Pasqua
Pro-tesi a Pasqua
L’esperienza della vita cristiana consegna ad ogni credente la consapevolezza che l’intero periodo quaresimale, in cui entriamo con fede, umilmente e risolutamente, ha senso solo se si è pro-tesi verso la Pasqua di risurrezione del Signore Gesù. La Quaresima è un itinerario che ha una meta ben definita: la Pasqua. Un itinerario di 40 giorni in cui la comunità cristiana, tesa verso la pasqua annuale, centro dell’anno liturgico e mistero fondante la fede cristiana, si prepara a vivere e a celebrare la Pasqua di risurrezione del Signore. Da sempre, la Chiesa ha vissuto come irrinunciabile l’orientamento pasquale della Quaresima: il primo “tempo liturgico” che la Chiesa antica ha articolato è stata la “cinquantina pasquale”, quel prolungamento gioioso della Pasqua, denso di sette settimane che andavano (e vanno) dalla domenica di Risurrezione a quella di Pentecoste. Solo alla fine del quinto secolo, la Quaresima appare come liturgicamente strutturata e inscindibilmente legata alla Pasqua.
È l’autorevole parola della liturgia quaresimale che, per prima, si incarica di indicarci la meta che conferisce senso e valore a questo tempo liturgico, riconsegnando alla comunità che celebra i divini misteri, il carattere preparatorio della Quaresima in rapporto alla Pasqua. A partire dal suggestivo rito dell’imposizione delle ceneri, da dove, ogni anno, prende l’avvio questo tempo “forte”: “O Dio, che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo e benedici questi tuoi figli, che riceveranno l’austero simbolo delle ceneri, perché attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio”. Il tempo quaresimale, dunque, come itinerario spirituale, vissuto appunto come tale, accompagna i credenti a vivere intensamente la celebrazione della Pasqua del Signore.
Così anche l’innodia: “Protesi alla gioia pasquale sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l’austero cammino della santa Quaresima” (inno dell’Ufficio delle letture). O si è pro-tesi alla “gioia pasquale”, che già pulsa in cuore e accende l’orizzonte, o sarà ben difficile assumere e vivere la Quaresima come esperienza salvifica, salutare, ri-creativa. Già gioiosa perché tutta irrorata dalla Pasqua. È sempre possibile ciò che Papa Francesco fotografa nella Evangelii gaudium 6: “Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua”.
E ugualmente nel primo prefazio del tempo quaresimale: “Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore”. La Quaresima, perciò, è da vivere come la preparazione gioiosa alla Pasqua, così da attingere a quella pienezza di vita nuova donata dal Figlio Gesù.

Essere sobri e anche convintamente penitenti, digiunare puntualmente e largheggiare nell’elemosina, ma privi del deciso orientamento alla Pasqua, privi della sua gioia e della sua luce, diventa solo un presupposto insipiente per celebrare la Pasqua (oltre che privo di autentico beneficio spirituale). Privata della tensione alla Pasqua, la Quaresima, considerata come un tempo a sé stante, come “tirocinio tecnico” di sforzo e di riappropriazione di sé o tempo di rafforzamento di precari equilibri “spirituali” o di riconquista del favore divino… si affloscia, perdendo la sua stessa identità e non potrà, così, più offrire il suo inestimabile dono di grazia, di dinamismo, di cambiamento. Oltre che ad innescare una visione pericolosamente distorta e caricaturale della vita cristiana e di ogni itinerario di vita cristiana.
Iniziare il cammino liturgico della Quaresima puntando decisamente e gioiosamente verso la Pasqua, risveglia nei battezzati e nei catecumeni quelle consapevolezze capaci di sostenere l’impegnativo cammino di conversione perché, giunti alla Veglia pasquale, realmente si possa riconoscere nel canto dell’Exultet, il riflesso genuino della gioia del proprio cuore.
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua è scegliere lo stile di Dio: tutto si è dato a noi nel Figlio e, in questa offerta, c’è per ognuno la possibilità e la grazia di farsi tutto dono. Questa è l’autentica ascesi quaresimale perché si possa approdare, interiormente rinnovati, alla Pasqua. La conversione non corrisponde ad un ritocco di facciata, ad un maquillage spirituale o morale: quello che ci necessita per vivere è un ri-orientamento, un ri-volgimento al Vangelo di Gesù e, da lui, ricevere la vita nuova che egli promette a tutti coloro che lo accolgono come Parola di Dio e sono disposti a compierla nella vita.
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua significa convertirsi, cioè credere – che significa, appunto, “dar credito” – al Vangelo, interiormente con-vinti che il Vangelo sia la verità e il tesoro ineguagliabile della propria vita. Ma dar credito al Vangelo significa ri-orientare i desideri: dismettere quei desideri che sappiamo antievangelici, vecchi, “cattivi” – captivus è colui che è prigioniero – che ci rendono prigionieri di egoismi, di pregiudizi, di visioni contraffatte di Dio, degli altri, di sé, per iniziare a desiderare ciò che il Padre desidera e che ha manifestato negli stili di vita del Figlio Gesù, nei suoi sentimenti. Da lui apprendiamo ciò che conta e merita di essere perseguito nella vita. Ognuno sa, per esperienza personale, che non ci si distacca da ciò che rassicura, che è noto, che paga subito e in contanti, che è diventato seconda pelle, se non si è afferrati dal desiderio e dalla ricerca di un di più, di qualcosa o Qualcuno per cui valga la pena cambiare, ri-orientare o dismettere i desideri vecchi e rassicuranti. Se non si prova il desiderio intenso di vivere in modo nuovo, altro da quello abituale, si rimane saldamente ancorati al vecchio(ci siamo soffermati sul tema del desiderio e del desiderare nel messaggio di Quaresima-Pasqua del 2015, Al pozzo oltre il pozzo. Scavando i desideri).
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua significa ri-apprendere umilmente a pregare. La Quaresima è una formidabile, intensa, eccellente scuola di preghiera. Scuola, non diplomificio veloce e a buon mercato.
Le preghiere codificate, il rito, le formule, – quando la preghiera, il dialogo personale e intimo con Dio è trascurata o inesistente – possono diventare un perimetro sicuro e protettivo, fino a convincerci, pian piano, che tutto questo armamentario religioso, da solo, in automatico, possa bastare a garantirci di essere oranti discreti o, quantomeno, di aver assolto un precetto. Questo convincimento potrebbe attivare un atteggiamento mercantile: l’aver assolto il precetto produce un diritto, una carta di credito “spirituale” da presentare a Dio. E, qui, la coscienza, beatamente si adagia, rassicurata del fatto suo. Una certa routine legata alla fissità ripetitiva e rassicurante (spesso condita con una manciata di pigrizia e un pizzico di superficialità), può giocare brutti scherzi nella vita spirituale.
La preghiera, il dialogo con Dio, senza sosta, è da convertire, proprio come sopra ricordato: ri-volgere, ri-orientare, riscoprendo la gratuità della lode, la fatica e l’umiltà di chiedere, di impetrare e di piangere, la gioia libera di ringraziare, la sanante umiliazione di alzare le mani, di domandare perdono e di lasciarsi rialzare. La preghiera cristiana obbedisce ad un semplice e fondamentale principio, così espresso da Gregorio di Nissa: “Non mancherà mai lo spazio a chi corre verso il Signore […]. Chi ascende non si ferma mai, va da inizio in inizio, secondo inizi che non finiscono mai”.
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua non vuol dire, primariamente, mangiare meno cioccolato, stare meno in rete o limitare sigarette, alcolici, leccornie e svaghi. Significa, invece, fermarsi e accettare di guardarsi in faccia e in cuore, cominciando a sfilarsi maschere, a far cadere simulazioni e decidere di dismettere quelle stanche e invecchiate abitudini che mutilano la vita. È iniziarea liquidare, decisamente, ogni finta estetica religiosa: “Esistono, nelle grandi chiese cattedrali, sproporzionati candelabri d’altar maggiore, scolpiti nel legno tenero, laccati di bianco e decorati in oro zecchino. Colpiscono, hanno fascino, donano all’ambiente la solennità del tempio. Se si ha poi modo di avanzare ai lati dell’altare, si scopre lo scenario misero dei trucchi: non solo sul retro, ma anche ai lati, nessuno ha investito per dare la biacca, per stendere la foglia d’oro; talvolta persino il legno è solo sbozzato a bulino, nemmeno levigato o verniciato. E pertanto pericolosamente esposto alla ferocia del tempo e tarlato. Chi ne trovasse almeno una coppia nei solai e nelle sagrestie, potrebbe davvero – per tutto il tempo di Quaresima – porli accanto o innanzi alla mensa della celebrazione, come motivo visivo ai rischi di cui ogni uomo potrebbe essere vittima” (S. Toffolon). Il cammino di Quaresima è un percorso che abilita ad aprire gli occhi, illuminati dallo Spirito del Risorto, sulla verità più profonda di noi stessi.
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua significa anche ri-aprire gli occhi sugli altri, ri-orientarsi verso di loro. Solo quando “si frequenta Dio” e lo si accoglie in tutta la sua alterità e trascendenza, incontrandolo come amore gratuito ed eccedente, è possibile “frequentare l’umano” e guardarlo non come concorrente, né dall’alto in basso (e neppure viceversa), né con sguardo indifferente o giudicante o sprezzante o impaurito. Se è la Parola che ci consente di aprirci a Dio in una relazione che può realmente trasfigurare la nostra esistenza, è sempre la medesima Parola che ci abilita all’altro/altra, che consente di metterci empaticamente nella pelle altrui, di muoverci a compassione fino al punto di essere disposti a pagare di persona per soccorrerli, per aiutarli, per consolarli. Ma, per questo, necessitiamo di un rifacimento del cuore, diventato duro, addirittura pietrificato (la sklerokardìa di cui parla la Scrittura: cf Mt 19,8; Mc 10,5; 16,14), ispessito dall’egoismo e che, continuamente, si lascia imprigionare dal sospetto, dalle paure, dai pregiudizi. La parola di Dio, accolta nel cuore, ne sbriciola le parti pietrificate. L’anno scorso, proprio in questa stessa occasione, vi scrivevo: “Proprio perché il cuore è affetto da tale “pietrificazione”, proprio perché senza intelligenza, incapace di comprendere e discernere (cf Mc 6,52; 8,17-21) e capace, invece, di chiudersi alla compassione (cf Mc 3,5), di nutrire odio (cf Lv 19,17), gelosia e invidia (cf Gc 3,14); proprio perché può essere menzognero e “doppio/dípsychos” – aggettivo che traspone in greco una curiosa espressione ebraica che suona letteralmente “un cuore e un cuore: lev va-lev” (Sl 12,3; Gc 1,8; 4,8) – proprio per tutte queste ragioni, è solo nel cuore che si può giocare la partita della vita. Solo nel cuore può avvenire quella lotta spirituale capace di consegnarci alla libertà che partorisce all’incontro con Dio che, nella sua Parola, ci parla bocca a bocca (cf Nm 12,7-8)”.
Senza accoglienza e obbedienza alla Parola di Gesù, non si diventa compagni di viaggio delle donne e degli uomini del nostro tempo. Non si riconoscono gli altri come fratelli e sorelle, non li si può prendere sul serio e, ancor meno, farsi carico di loro. Sì, “Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio” (2Cor 1,3-4).
Entrare in Quaresima protesi a Pasqua in questo secondo anno del Sinodo, significa permettere alla Parola di “in-formare”, cioè di dare forma al nostro cammino sinodale, in modo che i tre cantieri diocesani indicati dai Presbiteri, dal Consiglio pastorale diocesano e dalla Consulta delle Aggregazioni laicali – “Cantiere della strada e del villaggio: mondo giovanile e scolastico”, “Cantiere dell’ospitalità e della casa: Parrocchia come casa accogliente nella quotidianità”, “Cantiere delle diaconie e della formazione spirituale: mondo della carità e ascolto della Parola” – ri-sentano, insieme, in questi mesi di incontri, la proposta qui contenuta, così da ri-volgersi, tutti e insieme, alla medesima Parola che desideriamo ritmi il nostro cammino sinodale quaresimale verso la Pasqua del 2023. È il primo ed essenziale segno di reale sinodalità, unito, inscindibilmente, alla partecipazione attiva, creativa e responsabile, un’esigenza, questa, tutta battesimale: “La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale. Come afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1Cor 12,13). Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni” (Papa Francesco, Discorso di apertura del Sinodo, 21 Ottobre 2021).
Un itinerario con un centro: il Battesimo
Se la Pasqua è simbolo reale della vittoria di Dio sul male e sulla morte e inaugura un’esistenza nuova caratterizzata dalla condizione di essere fatti figli nel Figlio, la Quaresima ci introduce alla comprensione vera e profonda di questo dono divino, abilitandoci a vivere tale condizione, soprattutto attraverso la preparazione al battesimo dei catecumeni e la memoria viva, grata e feconda del proprio battesimo, per coloro che già lo hanno ricevuto.
“La Quaresima è tempo di salvezza. Essa non è fatta da mano d’uomo; ci è preparata da Dio e sgorga, come acqua di salvezza, dal costato squarciato e glorioso del Crocifisso […] La grazia della Pasqua ci raggiunge e ci porta fin dal primo passo della Quaresima: non ci muoveremmo mai verso la Pasqua, se essa non ci chiamasse e non ci sostenesse con la sua grazia! La Quaresima è un cammino che ci fa passare ‘da questo mondo al Padre’, dalla lontananza di Dio all’incontro con lui nella comunione con i fratelli. Proprio come accadde a Israele, da Dio tratto dall’Egitto per fare con lui un’alleanza. Questo passaggio dalla schiavitù e dal peccato al Padre, lo chiamiamo conversione: esso è grazia e risposta della libertà, è ritorno a Dio e comunione con i fratelli, è, in una parola, cammino verso l’Alleanza. La Quaresima ci inserisce quindi nella storia della salvezza, chiamandoci a vivere oggi, l’evento dell’esodo; meglio ancora, l’evento di cui l’esodo è profezia, cioè la Pasqua del Signore. La comunità cristiana è già nella gioia pasquale, costituita com’è da rinati dal battesimo, plasmata dall’alleanza, nuova ed eterna, pattuita nel sangue di Cristo, l’agnello che toglie il peccato del mondo; però essa è ancora anche ‘in Egitto’, non è ancora totalmente libera dal ‘lievito’ del peccato e porta sempre in sé il germe della morte. Per questo deve fare ogni anno il cammino del popolo nel deserto, o forse, meglio, il cammino di Gesù verso Gerusalemme, in una salita di conversione dal peccato e di passaggio al Padre” (M. Cè).
La Chiesa, santa nel suo capo, Gesù Cristo, peccatrice in ognuna delle sue membra, sempre, ma in questi giorni santi in modo tutto particolare e più consapevole, è chiamata a fare memoria del battesimo che, in questo itinerario quaresimale, resta il centro, l’origine della sua vocazione alla santità e della sua chiamata a vivere i sentimenti di Gesù in una conversione permanente. Quest’anno, la liturgia delle Parola delle domeniche di Quaresima (il ciclo A), ci offre un aiuto concreto per riattivare la memoria del battesimo, delineando un itinerario battesimale ben articolato attraverso alcune pagine del Vangelo di Giovanni: la Samaritana (Gv 4,5-42), il cieco nato (Gv 9,1-41) e la risurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-45). Davvero, quest’anno, nella liturgia domenicale, ci è offerta una grande e luminosa mistagogia del battesimo a cui prestare un’attenzione particolare, per entrare in una cresciuta consapevolezza del legame indissolubile che corre tra il battesimo ricevuto (o da ricevere) e la Pasqua di risurrezione di Gesù.
Anche nella Chiesa di Alghero-Bosa, i nostri catecumeni vivranno questo tempo liturgico come tempo di purificazione e di illuminazione, attraverso i vari passaggi previsti dal Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti (RICA), soprattutto con gli scrutini e le consegne, così da vivere, guidati, una vera purificazione del cuore e una più intima e profonda conoscenza di Cristo Salvatore. Per ciascuno di noi, già arricchiti dell’inestimabile dono del battesimo, questi 40 giorni sono un tempo favorevole per rendere ancora più autentica la nostra identità di figli di Dio nel Figlio Gesù, figliolanza ricevuta in dono proprio nel battesimo, che è immersione nella morte e risurrezione del Signore (cf 1Pt 3,18-21). Risuonano quanto mai nitide e trasparenti le parole di San Giovanni Paolo II consegnate alla Chiesa nella Novo millennio ineunte il 6 gennaio del 2001: “Se il battesimo è un vero ingresso nella santità di Dio attraverso l’inserimento in Cristo e l’inabitazione del suo Spirito, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’insegna di un’etica minimalistica e di una religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno ‘vuoi ricevere il battesimo?’ significa al tempo stesso chiedergli: ‘vuoi diventare santo?’. Significa porre sulla sua strada il radicalismo del Discorso della montagna: ‘Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste’ (Mt 5,48)” (Nmi 31).
In questo tempo liturgico, che, provvidenzialmente, ogni anno, ci viene donato come “tempo favorevole” (cf 2Cor 6,2), più che affastellare tante iniziative pastorali per vivere intensamente la Quaresima in vista della Pasqua, può essere di grande giovamento spirituale intensificare, invece, il ricordo del battesimo. La memoria grata e sempre fruttuosa di bene, di quella figliolanza divina, di quella appartenenza alla Trinità santa, di quella possibilità semplice e vertiginosa, di poter amare con lo stesso cuore di Dio, attuatisi nel battesimo, è la più adatta preparazione alla Pasqua.
Nell’ultimo Natale vi scrivevo augurandovi e augurandomi di “sperare ferocemente insieme”. Oggi, in questa Quaresima, decisamente protesi verso la Pasqua, ci auguriamo vicendevolmente di ri-cor-dare, di portare e mantenere a cuore, instancabilmente, il dono della nostra con-formazione al Figlio Gesù, ricevuta in dono nel battesimo.
Sananti opere di penitenza
La pagina evangelica che, come un solenne portale d’accesso inaugura, nel Mercoledì delle Ceneri, i quaranta giorni quaresimali, che conducono i credenti a vivere, poi, santamente e gioiosamente la “cinquantina pasquale”, è il testo del Vangelo di Matteo 6,1-6.16.18, che condensa lo stile penitenziale cristiano in una triade di opere sananti,opere terapeutiche, opere guaritrici: elemosina, preghiera, digiuno, centrali nella spiritualità ebraica, reinterpretate da Gesù per i suoi discepoli e riproposte dalla Chiesa per questo santo itinerario quaresimale verso la Pasqua. Un detto rabbinico, attribuito a Simeone il Giusto, afferma che “Su tre cose è poggiato il mondo: sulla Torah, sul culto e sulle opere di misericordia” (Pirqè Abot I,2). Nel nostro testo, disposte in modo diverso, sono presenti due di questi “pilastri”: culto e preghiera, infatti, sono sinonimi, così come elemosina e opere di misericordia. Il terzo, il digiuno, che non coincide con lo studio della Torah, è, tuttavia, tra le pratiche religiose propedeutiche allo studio di essa (cf Dt 8,3). Gesù indica ai discepoli questi tre principi cardini, chiedendo loro di viverli nella “giustizia giusta” – come il Padre vuole – e sotto il suo sguardo, “nel segreto”.
La liturgia, instancabilmente, ci prende pedagogicamente per mano e ci introduce nella celebrazione del mistero e nella comprensione dei testi biblici e dei segni liturgici: “Signore […] fa’ che mediante le opere di carità e penitenza, vinciamo i nostri vizi, e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio” (orazione sopra le offerte del mercoledì delle ceneri); “O Dio misericordioso […] tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna” (orazione colletta della terza domenica di Quaresima). Opere vittoriose, dunque, capaci di vincere “[i nostri] vizi” e, così, “liberati dal peccato”, ci conducono a celebrare in verità la Pasqua del Figlio.
Elemosina, preghiera, digiuno, opere di penitenza sanante, nella grande tradizione della Chiesa sono state sempre viste e vissute come indisgiungibili e inanellate: non soltanto mai l’una senza l’altra, ma anche una generatrice dell’altra, l’una corroborante l’altra, l’una innervante l’altra: “Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa sola e ricevono vita l’una dall’altra. Il digiuno è l’anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le divida, perché non riescono a stare separate. Colui che ne ha solamente una o non le ha tutte e tre insieme, non ha niente. Perciò chi prega digiuni. Chi digiuna abbia misericordia” (Pietro Crisologo, Discorso 43).
Anche in questi nostri giorni, così complessi, penati, ammalati, guerreggiati e, materialmente, terremotati – la tragedia in Turchia e in Siria ha appena tragicamente colpito milioni di persone – la madre Chiesa non rinuncia a riproporre questa prassi penitenziale e sanante, che conserva sempre la sua carica profetica. Nel testo di Matteo 6,1-6.16.18, ci viene offerta una particolare visione dell’umano. Meglio ancora, in esso è contenuta una vera “antropologia teologica” che pone la persona umana di fronte a quelle tre sue componenti, quelle sue “origini”, con cui è chiamata a intrattenere legami autentici e costantemente ricentrati: l’alterità, il rapporto con gli altri; la trascendenza, il rapporto con Dio; il digiuno, il rapporto con se stessi.
Sfortunatamente (e incomprensibilmente), dal testo proclamato nella liturgia proprio in questo portale di accesso alla Quaresima, sono stati estromessi i versetti 7-15: la preghiera del Padre nostro (che invece riporto, sotto). Un ammanco che è una devastazione non certo architettonica, ma, molto di più, per la comprensione dell’intero testo proposto dalla liturgia. Già la sua collocazione nel cuore del Discorso della montagna e del nostro stesso testo, dovrebbe suggerire la sua intangibilità, proprio per la comprensione autentica dell’intero brano proclamato il primo giorno di Quaresima. Il pilastro centrale, a cui fa riferimento Gesù, come già detto, è la preghiera: non è un caso che il Pater campeggi al centro del brano, consegnato tra le esortazioni sulla preghiera e quelle sul digiuno (6,9-15). La figura del Padre domina sull’intero Discorso: è lui che, da Padre, ama la persona umana ed è pronto ad intervenire per sostenerla nella vita (cf 6,25-34; 7,7-11). Il Vangelo di Matteo è, tra i Sinottici, quello a cui sta più a cuore la paternità di Dio: nei cinque grandi Discorsi in cui è articolato il primo Vangelo, l’autore è attentissimo a presentare il volto del Padre che ha cura di tutte le sue creature. La sfida per il discepolo è fidarsi di lui, dargli credito incondizionato. Chi si fida e affida così, è libero da sé stesso e, nella relazione con il Padre, trova la sua ricompensa, gustando il frutto del suo affidamento. Alle parole di Gesù contro la “pubblicità” della preghiera (vv. 5-6), nel testo seguono immediatamente le parole della preghiera per eccellenza, il “Padre nostro”, che, per noi cristiani, è “modello di ogni preghiera”. Queste spiegano quelle! Se il segreto della paternità divina è proprio la rivelazione centrale del Discorso della montagna, si comprende la totale stonatura, la stridente cacofonia con le parole di Gesù dei versetti 5-6 sui simulatori della preghiera che la strombazzano e la pubblicizzano. Quanto non-filiale, quanto agli antipodi della paternità del Padre, quanto alieno da lui appare tale atteggiamento, lo svelano, appunto, i versetti 7-15, dove Gesù insegna ai discepoli la preghiera del “Padre nostro”. Purtroppo, nel testo liturgico proclamato il Mercoledì delle Ceneri, non viene letta. La lettura personale e comunitaria del testo nella sua integrità, sarà impegno e ricchezza di comprensione per tutti:
State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. Amen/in verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. Amen/in verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
[Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe].
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Amen/in verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Matteo, per riportare le parole di Gesù, userà in tutti e tre i detti, il medesimo schema:
- Quando[fai l’elemosina, pregate, digiunate]
- non siate come gli attori/simulatori
- i quali [o poiché]…
- Amen/in verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa
- tu invece [facendo l’elemosina, pregando, digiunando]
- fallo in segreto
- e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà
Giustizia: compimento amoroso della Torah
Il brano evangelico, come ricordato, è nel cuore del Discorso della montagna (cc. 5-7): Gesù chiamati a sé i discepoli (4,18-22) e attirata una grande folla (4,23-25), indica, per entrare nel Regno, una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei (5,20). Il brano riportato, poi, segue il versetto provocatorio del Discorso della montagna: “Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (5,48). Dal testo e dal contesto si può facilmente dedurre che Gesù sta indicando, come giustizia superiore, la perfezione dell’amore del Padre, quella eccedenza amorosa di chi “fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e su gli ingiusti” (5,45).
Ma come poter vivere così per essere riconosciuti, dal Padre, come figli?
L’orizzonte entro cui Gesù porta i discepoli a ricomprendere i tre pilastri della loro tradizione religiosa è quello della giustizia/dikaiosyne, parola-chiave nel Discorso della montagna, dove appare cinque volte. Giustizia, in tale contesto, sta ad indicare l’atteggiamento di chi, senza compromessi e in misura colma, abbraccia la volontà del Padre obbedendo alla Torah. È la volontà manifestata nelle Scritture di Israele e ridefinita e portata alla sua pienezza nella parola e nella persona di Gesù di Nazaret.
Per vivere da figli è necessario riappropriarsi del significato primigenio della Torah interpretata e vissuta da Gesù, nella ‘imitazione’ dell’agire del Padre.
“Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta” (6,33). In ciò che Gesù sta insegnando, giustizia e Regno sono inscindibili: elemosina (6,1-4), preghiera (6,5-15) e digiuno (6,16-18), ri-indirizzate dal Maestro – “invece, tu!” – sono tre modalità concrete per imparare la giustizia (= agire come il Padre desidera), entrare nel Regno, essere riconosciuti figli.
È possibile praticare una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei, perché Gesù è ormai presente: la sua persona e la sua parola, portano a pieno svelamento l’intenzione originaria del Padre.
Non recitate!
Il termine usato da Gesù, in riferimento a scribi e farisei – la cui “giustizia”, il cui stile e la cui motivazione egli indica come inadeguata – è hypokrités, ipocrita, simulatore. Il mondo greco indicava con hypokrités il suggeritore e l’attore: posta una maschera sul volto, rappresentava o imitava qualcuno sul palcoscenico. Il simulatore è colui che fa di tutto per essere guardato. La collocazione “teatrale”, dunque, è di rara chiarezza.
In alcuni testi del Vangelo di Matteo, scribi e farisei, sono citati per la loro doppiezza: una cosa è il loro mondo interiore, altro ciò che inscenano, tutti preoccupati di apparire giusti, onesti, religiosi (cf Mt 15,7; 22,18; 23,13). In aramaico, il termine corrispettivo hanefa, significa “perverso/empio”, parola che, probabilmente, viene evocata anche in questi testi. L’ipocrita può essere un empio (Mt 24,51) e un cieco (Mt 7,5): essendo doppiogiochista e disonesto, il suo giudizio è alterato e risulta non credibile.
Senza esprimere giudizi, Gesù descrive fatti. Fatti che appaiono fuorvianti e snaturati, tanto è vero che intima ai suoi “State attenti a non…” (v.1). Agire da simulatori/attori, non sul palcoscenico ma bensì nell’ambito del sacro e nelle dinamiche relazionali della vita; mettere in scena comportamenti preoccupati solo del consenso, senza alcun sapore di autenticità e di coerenza, spinge Gesù a rivolgersi ai suoi indicando una modalità alternativa: “Invece, quando tu…”. Gesù, in fondo, cerca di condurre i discepoli a porsi la domanda: ma sotto gli occhi di chi agisco? Chi deve registrare la “giustizia”, il movente per cui agisco? Chi o cosa anima i gesti che faccio? Per chi insceno ciò che faccio? Due sono le possibilità concrete di risposta: o conduco un’esistenza mossa unicamente dal desiderio di piacere a Dio o vivo da “attore”, per essere visto, notato e apprezzato dalla “platea”.
Vivere sotto lo sguardo di Dio per piacere a lui, presuppone una persona rivolta, attenta, tesa a Dio, mossa dall’unica preoccupazione di piacere a lui. Decentrata. Ogni “ricompensa” si attende solo da lui che vede nel cuore.
Vivere sotto lo sguardo della platea/pubblico, indica una persona rivolta, attenta, tesa a se stessa, mossa dall’unica preoccupazione di piacere e di piacersi. Autocentrata. Ogni “ricompensa” si esaurisce nello sguardo e nell’approvazione di chi guarda. Chi, tuttavia, vede lo spettacolo, in verità coglie solo la… carrozzeria, l’esterno, la scorza. “Bisogna cercare la ricompensa di Dio, non degli uomini: bisogna agire nel segreto, non dare spettacolo. Ma la ricerca della ricompensa di Dio non è anch’essa una sottile ricerca di sé? Matteo è convinto che, mentre la ricerca dell’approvazione degli uomini è alienante, impedisce la verità e l’autentica giustizia, la ricerca dell’approvazione di Dio è invece liberatrice, favorisce il vero amore e la giustizia. Quando si agisce per Dio non c’è il pericolo – che invece esiste quando si agisce per gli uomini – di cadere nella demagogia, nell’adulazione e nel compromesso interessato. Al cospetto di Dio non c’è spazio per gli opportunismi” (B. Maggioni). Quanto più conta lo sguardo di Dio sulla mia vita e nelle mie scelte, tanto meno contano gli infiniti sguardi altrui a cui dover piacere, a cui dover render conto, da cui ricevere approvazione e plauso o, al contrario, di cui temere il giudizio, la valutazione severa, la stroncatura totale. Vivere sotto lo sguardo del Padre e piacere a lui solo, è liberante. Vivere sotto mille sguardi di altrettanti inflessibili censori, può essere esperienza diametralmente opposta.
Gesù mette in guardia i suoi ascoltatori e noi: si può praticare la “giustizia” – nell’accezione sopra ricordata – da attori, da stars, recitando una parte davanti ai tanti spettatori che circondano la nostra vita, per essere ammirati, applauditi, considerati. È indispensabile dismettere l’atteggiamento malsano – umanamente e religiosamente corrotto –, che Gesù vede inscenato lì dove proprio non si dovrebbe e da chi, tutt’altro atteggiamento, ci si aspetterebbe: “State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini”. Le “opere buone” per eccellenza – elemosina, preghiera e digiuno – fatte per ottenere buona fama, considerazione e vantaggi, “davanti agli uomini”, sono invisibili a Dio, egli non le vede! Mentre egli vede – bene! – il cuore, lì dove ogni gesto esterno, è architettato, costruito, plasmato e, quindi, riceve il suo marchio di verità o di falsità. “Per costoro non v’è alcuna ricompensa, perché l’hanno già ricevuta dagli uomini: come attori e protagonisti della propria vita si sono sforzati di produrre un risultato tutto umano, ‘davanti agli uomini’ ma non riceveranno niente dal Padre, per il semplice motivo che lo hanno estromesso dalla relazione. La ricompensa di cui parla Gesù non è la paga: per capire di che cosa si tratta, occorre tener presente la prospettiva delle beatitudini. La ricompensa è il Regno, che si identifica con la salvezza: ‘Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli’ (Mt 5,3). A chi si apre alle esigenze del Regno, fin da ora è promessa una novità di vita come dono trascendente e indipendente da ciò che l’uomo fa di meritorio. Questo dono è la partecipazione alla vita divina nella relazione col Padre che è nei cieli. Solo chi rinuncia ad essere ipocrita, cioè attore e falso nel praticare la propria religione, può accedere all’incontro col suo volto” (L. Rossi).
La parola di Gesù ci educa ad essere uomini e donne autentici, non personaggi finti che recitano. Un detto nostrano ci ricorda – anche se declinato al maschile, vale anche per l’altra metà! – “Ki non bade homine, non bade nudda”: se non c’è l’uomo, la persona, una umanità vera e densa, non c’è nulla! Nessuna sovrastruttura o ruolo o posa o fama o titolatura ci possono dire qualcosa. Gesù spalanca prospettive per crescere nella libertà, sciogliendoci dai tanti lacci che ci co-stringono in un’immagine da difendere, in un personaggio da sdoganare, in un plauso da consolidare, in un ruolo da tutelare. Lo spessore umano e quella “giustizia superiore” indicati da Gesù, sventano il rischio di essere marionette rigonfie che, prima o poi, si ritrovano afflosciate perché vuote.
Elemosina: compimento gioioso della giustizia
Nei primi quattro versetti matteani, Gesù chiama in causa la prima “opera buona” della spiritualità giudaica: l’elemosina. Lo scenario è quello dei giorni penitenziali inaugurati dal suono dello shofar, il corno di montone, dove la preghiera “nelle piazze e nelle strade” veniva accompagnata dall’elemosina e dal digiuno. Le fonti giudaiche, non raramente, mettono in guardia contro un uso distorto dell’elemosina trasformata in mezzo per acquisire prestigio e popolarità. Molto eloquente, per il confronto ardito, è un detto attribuito a Rabbi El‘azar: “Chi fa l’elemosina in segreto è più grande di Mosè nostro maestro” (Baba’ Batra’ 6b).
Se dell’attore/simulatore, nel suo habitat naturale – il teatro – è apprezzata grandemente la sua arte simulatoria, il suo calarsi in tanti personaggi, il suo saper attirare l’attenzione degli spettatori, nel contesto evocato da Gesù, la simulazione è non solo fuori luogo, ma assurda. Colui che dà l’elemosina simulando, agisce mentendo: adempie il precetto non per amore di Dio o di chi chiede la sua attenzione e benevolenza, ma per amore di se stesso, nel tentativo di favorire la propria immagine e il proprio tornaconto religioso e sociale. La ricompensa, proprio per questo, è già stata ricevuta e degustata, perché è stato raggiunto lo scopo preventivato: l’attenzione e l’elogio dei circostanti. Tutto e solo questo.
Agendo, invece, nel segreto – “non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” – il discepolo sa contrastare l’esibizionismo che è sempre pronto a esigere la tangente in ogni (buon) gesto: Gesù chiede al discepolo di saper prendere le distanze dal proprio gesto buono, rinunciando, in fondo, a quel tutto e subito che ci ammalia così tanto e mollare la presa sulla soddisfazione immediata che viene dal plauso pubblico del bene compiuto. Il Padre sa ben provvedere al figlio con la sua ricompensa e questi, conoscendo il Padre, rinuncia ad ottenere, seduta stante, il suo riconoscimento per l’elemosina fatta. Da figlio, lascia che sia il Padre a disporre i tempi e i modi della ricompensa.
Non si tratta, dunque, di mettere in movimento la mano, allungandola con qualcosa da dare: è il cuore che deve muovere la mano perché si compia la “giustizia” del Regno. Nella giustizia di cui parla Gesù, è la compassione che articola i gesti, imprimendovi così il sigillo dell’autenticità. Il verbo eleèo, da cui deriva il sostantivo elemosina, significa proprio “avere compassione”. Questo modo altro, indicato dal Signore, è in perfetta consonanza con l’intero Discorso della montagna: il rapporto con Dio e con gli altri, si gioca nel cuore. Da lì scaturisce la ricerca della “giustizia”: l’elemosina diventa così un atto di obbedienza alla volontà del Padre, un atto di perfetta giustizia. Nel nostro testo, l’elemosina è posta in un contesto relazionale: innanzitutto, è un gesto tra colui che offre e il Padre che è nei cieli e “che vede nel segreto”; da questo gesto vero – proprio perché inverato dalla relazione cordiale dell’offerente con il Padre – è attivata una relazione vera tra l’offerente e il ricevente, colui che è in necessità.
L’elemosina compassionevole, quella che concretamente fa spazio agli altri, ci spinge a far memoria della nostra comune origine umana: è il modo attraverso cui ci riappropriamo del nostro legame con ogni altro. Noi umani ci apparteniamo: non propriamente perché simili, ma proprio perché simili-diversi! Nelle opere di carità fraterna, l’essere responsabili – il dare risposta – verso chi la vita ha posto alle corde, ci concede la grazia di lasciarci interiormente toccare dalla fragilità altrui rendendoci così umani. Compiuta questa “giustizia”, siamo di Cristo e, quindi, figli, in Lui, del Padre.
È l’altro che svela me a me stesso. La drammaticità di tante nostre relazioni nasce dal fatto che, non riconoscendo la diversità dell’altro, non comprendiamo neppure noi stessi. Inizio a comprendere me stesso quando inizio a comprendere e ad accogliere l’alterità dell’altro. Meglio: comprendo chi sono, quando, con l’altro, si attiva una relazione. Ecco perché nel Discorso della montagna, Gesù pone al centro il Padre di tutti e il cuore di ciascuno.
La solida riflessione sia biblica sia filosofica del secolo scorso – basti pensare a Emmanuel Levinas, grande conoscitore della Bibbia ebraica e della letteratura giudaica legata ad essa, nonché grande filosofo – ci ha ricordato la necessità di passare dal principio di identità al principio di alterità, dal primato dell’io al primato dell’altro. Si vince il proprio egoismo nel momento stesso in cui si va verso l’altro e quando l’altro smette di essere periferico e marginale è perché, emigrando da me, ne ho colto la centralità. Proprio allora mi si impone, dal cuore, da dentro, una relazione di responsabilità. E in questa relazione, divento sia consapevole di me che responsabile dell’altro. Ciò concretizza la prossimità: ri-conosciuto l’altro in quanto altro, accetto di prenderlo in carico e proprio questo attiva la fraternità, nella quale si è pronti a donare qualcosa di proprio all’altro. Gratuitamente.
In questo nostro frangente storico, alluvionato da orde di parole e di messaggi, dove tutti si interessano di tutti, offrendo soluzioni (tanto spesso né pensate né richieste), esibendo amicalità fittizie e intemperanze sconcertanti, non è fuor di luogo ricordarsi che, ogni relazione con l’altro, diventa vera non quando si sanno “più cose” su una persona o si disquisisce in lungo e in largo su di essa, ma quando si cresce nella responsabilità verso di essa. Lo scopo di ogni incontro, dunque, non è semplicemente una conoscenza reciproca, quanto un rapporto di responsabilità, anche quando, sul versante dell’altro, può esserci ir-responsabilità. Certo è che l’unica risposta possibile ad un volto che mi si svela, è l’accoglienza.
L’altro che, in qualsiasi modo, mi tende la mano, pone in luce un aspetto dell’elemosina spesso disatteso ma di assoluta importanza: non si tratta solo di un gesto di generosa carità personale ma anche di un dovere di giustizia. Come si è detto sopra, giustizia/dikaiosyne, generalmente, in Matteo riveste un valore soggettivo: obbedire alla Torah. Tuttavia, nel mondo biblico e giudaico, “giustizia” ha anche il significato di buone opere/ma‘asim tovim e, addirittura, nella Settanta (traduzione greca delle Scritture ebraiche) e nell’ebraico rabbinico, giustizia/zedaqà significa proprio elemosina. Il versetto di Matteo 6,1, ben correttamente, può, dunque, essere letto: “State attenti a non praticare la vostra elemosina davanti agli uomini”. Elemosina, perciò, come giustizia da ristabilire. Quanta giustizia da ristabilire girando lo sguardo intorno a noi…
“L’elemosina allora ci interroga su quale sia la nostra apertura agli altri, ad ogni altro uomo, perché su questo si misura la carità non raffreddata. Ma il gesto dell’elemosina ci interpella su quale sia il nostro impegno per la giustizia, affinché la tanto sbandierata uguaglianza degli uomini e delle donne che abitano la casa comune e le nostre città sia veramente realizzata attraverso l’effettiva cura degli ‘ultimi’. Perché nell’elemosina la povertà viene compresa come frutto dell’ingiustizia. Nell’elemosina si restituisce e non si dona. E la vera elemosina può viversi solo se si è disposti a chiedere l’elemosina, a riconoscere cioè che siamo tutti poveri, siamo tutti accattoni. Il soccorso dell’altro non è un gesto di benevolenza, ma l’esigenza imprescindibile che deriva da una profonda comprensione di noi stessi. Se la povertà del fratello ci apre alla nostra povertà ci consente di tenere caldo il cuore, perché l’amore non si raffreddi, in noi e nella città degli uomini. L’amore, l’ingrediente essenziale per dare ‘sapore’ (ed anche ‘sapere’) alla vita; per cambiare rotta e inventare nuovi percorsi di convivenza nella casa comune – il pianeta che abitiamo – e nelle nostre città” (C. Lorefice).
Preghiera: imparare il Padre
I versetti 6-8 riportano le parole dove Gesù si dissocia dalla spettacolarizzazione della preghiera “negli angoli delle piazze” e chiede ai suoi di “stare attenti, di guardarsi dal farlo”. Paradossalmente, anche la preghiera può essere usata come mezzo di affermazione di sé. Preghiera che è, invece, il luogo privilegiato per imparare a vivere nella relazione con il Padre. Spazio privilegiato per imparare il Padre. Pregare è fare spazio al Padre, senza usurparglielo. Proprio per questo, i versetti 7-15, non proclamati nella liturgia del mercoledì delle ceneri, come già accennato, risultano indispensabili per la piena comprensione del testo evangelico. La moltiplicazione delle parole di cui parla Gesù al v. 7 – chiamando questa volta in causa i pagani e non scribi e farisei – è segno di un rapporto insano con Dio, del quale il Figlio dice che “sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate”. Dimenticando ciò, l’orante tenta di catturare l’attenzione di Dio, di “addomesticarlo” (caso mai insegnandogli anche come essere e fare Dio…), blaterando e catapultando verso di lui caterve di parole. Troppe e inutili, dice Gesù. Il suo richiamo, tuttavia, non vuole relegare la preghiera “in camera”, decretando la fine della preghiera comunitaria: questo luogo appartato, intimo, riservato e non in vista, lontano dalla “sinagoga” e dalla “piazza” e a “porta chiusa”, è indicato piuttosto come il luogo del dialogo intimo con il Padre, vero scopo della preghiera. Liquidando, così, ogni altra motivazione della preghiera.
È la consegna della preghiera del “Padre nostro”, con le parole introduttive di Gesù sull’inutilità delle troppe parole rivolte a Dio – vv. 7-8: “Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate – e le parole conclusive sul perdono – versetti 14-15: “Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe” – a costituire l’antidoto al modo manipolatorio, esibizionistico e strumentale della preghiera.
A questo riguardo, molte pagine dei Padri orientali risultano illuminanti oltre che saporitissime da un punto di vista letterario. Questi autori indicavano come esistesse una philautía, un “amore di sé” virtuoso e moltiplicatore di vita e una philautía dannosa e mortifera. Quando l’amor proprio diventa smisuratamente appassionato di sé, fa accartocciare la persona su se stessa, isterilendo l’apertura a Dio e agli altri e bloccando ogni sana fuoriuscita da sé: “Chi è caro a se stesso (philautía), non può amare Dio” (Diadoco di Fotice). L’amore implode quando se ne impedisce l’espansione, mentre nel suo aprirsi verso Dio e verso il prossimo, fuoriuscendo da sé, si dilata facendo fluire la vita.
La tradizione spirituale cristiana, sia orientale che occidentale, indica la preghiera insegnataci da Gesù come sanante, terapeutica per ogni forma smodata di philautía. Una preghiera che ci strappa da un Io che tenta sempre di strabordare, di essere invadente – diventando talvolta elefantiaco – così da riempire di sé l’intero orizzonte e, così facendo, spegnendo tutti e tutto. Quando l’Io esonda, si assiste ad un alluvionamento del Tu e del Noi circostante. Potremmo dire che, la preghiera del “Padre nostro”, “è la preghiera del Tu e del Noi, una preghiera dove ogni forma di protagonismo scompare: c’è il tu della relazione e il noi della condivisione. Per Matteo è lasciarci avvolgere e cambiare dalle relazioni che ci costituiscono: la relazione con il Padre e la relazione con l’altro” (N. Gatti).
In questi dodici anni condivisi insieme, tante sono le volte in cui la Scrittura santa ci ha ricordato che la preghiera è anzitutto ascolto. Detto paradossalmente: ascoltare è più che pregare, perché pone Dio e non Io al centro, riducendo così quella elefantiasi di protagonismo a cui ho sopra accennato. Un ascolto che spalanca alla presenza del Dio vivente che offre, a colui che lo ha incontrato, non qualche cosa di sé, ma offre se stesso come amore gratuito e incondizionato. Più l’incontro con Dio nella preghiera è mosso da una ricerca spasmodica, quasi saccheggiatrice – dove in fondo l’Io gestisce l’incontro – quanto più si necessita di appoggi: molte parole, assicurazioni, gesti rituali, coreografie. Se invece l’incontro è accoglienza della presenza data, pre-veniente, gratuita, incondizionata di Dio, allora quest’incontro si fa ascolto di Dio che parla.
Lo starter di ogni credito dato a Dio può essere solo la parola del profeta: “Parla Signore che il tuo servo ti ascolta” (1Sam 3,10). Non il contrario: “Ascolta Signore che il tuo servo parla!”. Solo l’ascolto riesce a riconoscere l’iniziativa di Dio, l’essere lui il vero soggetto agente del nostro stare davanti a lui “faccia a faccia” (cf Nm 14,14; Dt 5,4). Perciò, quando viene meno il primato dell’ascolto della Parola, ogni attività spirituale ed ecclesiale è fortemente tentata di diventare attività solo umana. Sottilmente, si è più tesi alla propria soddisfazione, ad un “assicurarsi” che non ad un accogliere la Presenza. Molta della ritualità irrigidita, delle formule depotenziate di vita e dei diversi armamentari, più o meno liturgici, invocati come salvaguardia della fede che rispuntano qua e là nella comunità credente, hanno in questo essersi dissociati dall’ascolto (e dunque preferendo condurre che essere condotti) la loro radice profonda. Si tratta, in fondo, del rispuntare di quell’arroganza spirituale, di quella sete di dominio che sempre, nella Bibbia, ha l’esito infausto di precludersi la visione del volto di Dio. “Ascoltare è meglio che il sacrificio” (1Sam 15,22): nel sacrificio, il rapporto Dio-uomo poggia infatti sulla fragile base dell’iniziativa umana, nell’ascolto esso si fonda sull’iniziativa di Dio […] Forse non riusciremo mai a scoprire tutto quello che si contiene in questo imperativo ‘ascolta!’. Esso è nello stesso tempo un appello al credere e un appello al fare. Dio vuole il “sacrificio di ascolto” (così lo possiamo legittimamente chiamare) prima ancora di aver manifestato il contenuto del suo parlare e del suo valore […]. Quando poi la parola è udita, essa è una parola da eseguire, non da conservare come una conoscenza iniziatica, come un talento non trafficato” (P. De Benedetti). Una Parola da compiere, ma proprio perché si compie in noi per la sua efficacia, perché parola di Dio. Ecco perché la speranza della conversione, come dono di Dio, anche in questa Quaresima 2023, ci colma di gioia, alleggerisce il cuore e rinsalda il passo verso la Pasqua. “La Parola di Dio è viva ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio: essa penetra fino a dividere anima e spirito, giunture e midollo e a distinguere i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4, 12)
“Grazie, Signore, che ancora ci doni la possibilità di ravvederci e salvarci: almeno in questo tempo si faccia più intensa la preghiera: tacciano le passioni, si convertano i cuori, si aprano le menti alla tua Parola che di giorno in giorno ci accompagna nel grande cammino verso la tua e nostra Pasqua. Grazie allo Spirito che ti ha condotto nel deserto per essere tentato anche tu, Signore, così ci puoi ancor più capire, noi siamo le tue tentazioni: sensi che urlano e magie e superstizioni e fame di prodigi e di grandezze, orgogli che impazzano, e la mente sempre più turbata e smarrita: Signore, benché non capiamo, noi ti crediamo per questo: perché sei tentato come uno di noi e tu per noi hai vinto, da solo: se ci vuoi salvare, Signore, non lasciarci soli nella tentazione. Amen” (D.M. Turoldo).
Digiuno: penitenti gioiosi e profumati
Anche nei versetti 6,16-18, come per l’elemosina e la preghiera, il Signore rimprovera i simulatori non per il digiuno in sé, ma per il modo in cui praticano il digiuno. Come detto, c’è un’anima dei gesti umani che invera il gesto stesso, una motivazione che non può essere disgiunta dalla materialità del gesto e che ne plasma sensatezza o insensatezza, verità o falsità.
Già il profeta Isaia aveva denunciato duramente la falsa pietà inscenata dal digiuno, puntando il dito sui disastri sociali perpetrati da questi simulatori di devozione, ma veri aguzzini degli altri, a iniziare da coloro a cui avrebbero dovuto garantire sussistenza perché loro dipendenti: “Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. Non digiunate più come fate oggi, così da fare udire in alto il vostro chiasso. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l’uomo si mortifica? Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?” (Is 58,3-7).
Nel testo evangelico, Gesù focalizza l’attenzione dei suoi su una modalità concreta, capace di svelare l’anima della scelta di digiunare: se digiuni, fallo con gioia. In italiano, facendo il calco letterale del testo greco, il versetto suonerebbe: “Quando poi digiunate, non diventate scuri d’occhi come gli attori/simulatori”. Come sappiamo, Gesù prenderà le difese dei suoi discepoli che non stavano digiunando, proprio perché colmi di una gioia incontenibile data dalla sua presenza tra loro, data dalla presenza dello “Sposo”(Mt 9,14ss).
Ogni forma di digiuno – di bocca, di lingua, di occhi, di udito, di piedi, di mani, di fantasia e, soprattutto, di cuore – ci educa a saper ponderare se “mangiamo”, se mettiamo “dentro”, vita o surrogati di vita, valori o disvalori, nutrienti o indigeribili, energetici o ipocalorici, prelibatezze o veleni … Vita o morte.
Ogni forma di digiuno ci educa innanzitutto all’umiltà: immediatamente, di primo acchito, quando agiamo in modo famelico, spesso non riusciamo a valutare, a scegliere, ad acconsentire o rifiutare in modo libero, responsabile. Umano.
Ogni forma di digiuno è uno spazio benedetto di discernimento per interrogarci, in verità, su cosa andiamo cercando, su cosa vogliamo, su cosa ci preme in cuore. È da questo discernimento che possiamo individuare il tesoro della nostra esistenza. Individuarlo, fa la differenza della vita. “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano, accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né trama, né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,19-21).
Ogni forma di digiuno ci conduce a scoprire la signoria salvifica di Dio, conducendoci a rinunziare a quel potere sulla vita e sugli altri che, ognuno di noi, in qualche modo e per qualche verso, si attribuisce e che scalpita in ogni cuore.
Ogni forma di digiuno ci abilita ad aprirci all’Altro e agli altri, ma apprendiamo anche ad entrare in contatto con noi stessi con maggiore onestà, con più realismo ma anche con più benevolenza.
Ogni forma di digiuno crea una condizione di mancanza, dove apriamo gli occhi accorgendoci che tanti “cibi” confezionati da noi, a noi non bastano, a noi non servono, per noi sono dannosi … E impariamo a chiedere un cibo altro, non preparato da noi, un cibo che ci sostenga e dia pienezza di senso ad ogni desiderio di vita, di verità, di libertà e di amore che portiamo dentro.
Ogni forma di digiuno ci dice di prendere sul serio la propria dimensione fisica, biochimica della vita, per non incorrere in quei “mali di vivere” in cui incappano o gli asceti scriteriati o gli iperconcentrati su di sé (e quindi iperpreoccupati) di ogni minima variazione o mutazione del proprio fisico.
Ogni forma di digiuno ci istruisce per instaurare un rapporto equilibrato con la nostra oralità: nodo dolente, soprattutto in questo nostro contesto culturale segnato da un consumismo folle, sfrenato. Disumano.
Ogni forma di digiuno ci accomuna, con più verità e tanto realismo, a tutti quei fratelli e sorelle che, proprio oggi, digiunano forzatamente di cibo, di casa, di cure e soprattutto di pace, di libertà, di dignità, di rispetto. Di vita.
Ogni forma di digiuno non può non sgorgare dall’attesa del ritorno dello Sposo, in una concentrazione spirituale vigile, densa, amorevole, su ciò che av-verrà: “Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”.
Ogni forma di digiuno, perciò, scaturisce dalla preghiera, dall’incontro intimo e segreto con il Padre e conduce all’amore fraterno: “il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame” (Papa Francesco).
È nel digiuno che possiamo intercettare, in noi stessi, quella fame radicale, quella che si mimetizza (ma senza essere muta, anzi!), in tutte le altre fami che ci attanagliano, ci strattonano e, non raramente, ci schiavizzano. È la fame di Dio, della sua Parola, di quei desideri abissali di verità, di libertà, di vita, di amore che sono cifra di Altro. “Non è certamente casuale che la prima tentazione di Adamo sia stata quella di mangiare il frutto dell’albero del bene e del male, così come la prima tentazione di Gesù, nuovo Adamo, sia stata di trasformare magicamente delle pietre in pane per soddisfare il proprio bisogno di alimentarsi. Non è neppure casuale, al contrario, che il sacramento per eccellenza della salvezza sia il pasto eucaristico, nel corso del quale l’avidità dell’uomo è convertita in umile comunione con il corpo del Risorto” (A. Morandi).
Un criptato convertirsi
Nel nostro testo evangelico, il termine kryptòs/segreto, in pochi versetti, viene ripetuto cinque volte. Elemosina, preghiera, digiuno, opere di giustizia per eccellenza – proprio perché opere che cor-rispondono alla volontà di Dio, che hanno a che fare direttamente con lui, con gli altri, con se stessi – esigono un unico testimone: il Padre.
Gesù dice ai discepoli che l’elemosina non solo va fatta “nel segreto”, ma è necessario che le mani del medesimo donatore restino paradossalmente all’oscuro del gesto di solidarietà, l’una dell’altra (vv. 3-4); così per la preghiera: non solo “nel segreto”, senza ostentazione e ostensione dell’incontro con il Padre, ma con l’accortezza supplementare di “chiudere la porta della camera” dietro di sé, dopo aver trovato il luogo meno esposto e meno accessibile ad altri, “la camera” (v. 6). Per mantenere il digiuno “segreto”, il Signore Gesù indica al discepolo, addirittura, una duplice attenzione: prima un’azione diretta, una scelta possibile solo “da dentro”, su volto e occhi (più che mai, in questo caso, “specchio dell’anima”, v. 16); poi, a completamento della prima – quasi un’azione di calcolato “depistaggio” per gli astanti – lavarsi il viso e profumarsi il capo.
Ed è lì, proprio lì, “nel segreto”, abitato dal “Padre tuo” e dove egli “vede” (vv. 4.6.18), che la “ricompensa” è offerta. Una e unica la ricompensa, già elargita “nel segreto”: il Padre stesso. Ricompensa è avere il Padre dei Cieli, il Padre del Figlio Gesù, come proprio Padre.
“Nel segreto” ognuno è se stesso e nessun infingimento serve o risulta di una qualche utilità: è lì, nella verità di se stessi, che Gesù ci invita ad abitare, a stanziarsi stabilmente; l’autenticità sta “nel segreto”, ciò che veramente si è, risiede lì. “Nel segreto” non si va per rifugiarsi né per crogiolarsi né per nascondersi. È il luogo, invece, della vita, dell’autenticità e della dolcissima esperienza della figliolanza. È “nel segreto” che le dimensioni che fanno la vita – relazione con gli altri (elemosina), relazione con Dio (preghiera), relazione con se stessi (digiuno) – trovano l’imprinting della loro autenticità: la gratuità.
Opere e stili
Il testo fin qui letto e meditato ci riconsegna l’elemosina, la preghiera e il digiuno come opere sananti di penitenza se lo stile è quello del Signore Gesù. Egli, come visto, chiede ai discepoli di deprivare queste opere sante dal propellente nocivo dell’ipocrisia, dell’esibizionismo, dell’ostentazione, della capitalizzazione, della contabilità, della spettacolarizzazione, della simulazione, della teatralità, dell’autocompiacimento e di animarle, invece, nella verità, nella autenticità e gratuità dei gesti, da figli davanti al Padre.
Opere e stili che, in questo modo cristiano, il credente impara a non sprecare, a non procrastinare, ad intensificare.
Opere e stili che abilitano a riconoscere Dio come Amore senza aggettivi, gli altri come altro-da-me e non concorrente, se stessi come dono da accogliere e non come fardello da trascinarsi o ingombro di cui schifarsi.
Opere e stili che guariscono ferite, strappano dall’autoavvitamento e dall’autosufficienza, spalancano gli occhi del cuore sulla verità che è Dio, che sono gli altri, che sono io stesso, che è il creato.
Opere e stili che disarmano dalla violenza cuore, labbra e mani, che riescono a domare ipocrisie, doppiezze e tradimenti, che smascherano contraffazioni affettive, parodie esistenziali, falsificazioni identitarie.
Opere e stili capaci di portare luce nelle periferie dolenti e impenetrabili del cuore, nei meandri degli infiniti smarrimenti, nell’insulsa pretesa di sentirsi, comunque e (quasi) sempre, migliori degli altri.
Opere e stili che concedono di non più arrossire nel chiedere, supplicare, invocare, attendere e rallegrano il cuore nel perdonare, ringraziare, sovvenire, accogliere.
Opere e stili che sfoltiscono l’inutile, fanno scorgere l’essenziale e riescono a dare nome esatto a lusinghe ammalianti e inconsistenti.
Opere e stili che restituiscono autonomie perdute, che strappano di mano password a bisogni autoproclamatisi vitali, che smontano automatismi schiavisti.
Opere e stili che sospingono gli interessi ad emigrare dal proprio interesse, che suscitano passione per la prossimità, che allenano i sentimenti a com-prendere, a con-dividere, a con-vivere, rendendo così capaci di vera com-passione.
Opere e stili che sgonfiano la smania di brillare sotto i riflettori, di essere additati come superstar, di attirare l’attenzione e che, invece, gioiscono di stare “in camera”, “nel segreto” e lì, attendere la “ricompensa del Padre” che, proprio perché non cercata, sarà eccedente, incommensurabile, sproporzionata.
La parola di Gesù su come vivere l’elemosina, la preghiera e il digiuno, sospinge a cogliere il perché. Il Signore spinge ad una concretezza della fede che si deve poter tradurre, appunto, in opere e stili. L’attenzione a Dio e agli altri, resa visibile in gesti concreti, mette il discepolo a riparo dal rischio sempre possibile, di una fede domiciliata più in mondi ideali, nei sogni o in fumosi e immaginifici scenari.
La prossima quinta domenica di Pasqua, 7 Maggio, la nostra Chiesa celebra la Giornata per il Fondo Episcopale di Solidarietà. Tutte le offerte raccolte durante ogni celebrazione eucaristica in ciascuna Parrocchia e in ciascuna Chiesa destinata al culto divino, confluiranno in detto Fondo.
Domando ad ogni parroco e ad ogni presbitero di accompagnare le comunità e i singoli a crescere nella consapevolezza di poter e dover diventare fratelli, condividendo con chi fa fatica a vivere.
Moltissimi sono coloro che, con generosità, discrezione e sacrificio, hanno offerto del proprio per sovvenire altri, neppure conosciuti, eppure diventati segno di attenzione e di compassione. A tutti e a ciascuno il mio grazie e quello dell’intera comunità cristiana.
Complessivamente, in questo decennio, sono stati raccolti 932.622.90 euro ed erogati 864.561,08 euro.
Entro il mese di maggio ogni presbitero depositerà le offerte raccolte in tale giornata presso l’Economato diocesano. Come ogni anno verrà reso noto, tramite il giornale diocesano Dialogo, quanto la carità avrà saputo smuovere la nostra generosità.
Pongo a sigillo di queste pagine una “Catechesi sulla santa Pasqua”, attribuita allo Pseudo-Giovanni Crisostomo, che non ha bisogno di commenti, per la sua incisività, arditezza e luminosità pasquale e che vi consegno come viatico prezioso da gustare nei prossimi novanta giorni di grazia:
“Chi ha fede ed è amico di Dio gioisca in questa bella festa! Il servo riconoscente entri felice nella gioia del suo Signore (cf Mt 25,21-23)! Chi ha sopportato il peso del digiuno, riscuota ora la ricompensa. Chi ha lavorato fin dalla prima ora, riceva oggi il giusto salario; chi è venuto dopo la terza, renda grazie e sia in festa; chi è giunto dopo la sesta, non esiti: non subirà alcun danno; chi ha tardato fino alla nona, venga senza esitare; chi è giunto soltanto all’undicesima, non tema per il suo ritardo.
Il Signore è generoso, accoglie l’ultimo come il primo, accorda il riposo a chi è giunto all’undicesima ora come a chi ha lavorato fin dalla prima (cf Mt 20,1-16). Fa misericordia all’ultimo e serve il primo; a quello dona, a questo regala con profusione, rende onore alle azioni, loda le intenzioni.
Entrate tutti dunque nella gioia del nostro Signore, primi e secondi ricevete la ricompensa; ricchi e poveri, danzate insieme; asceti e indolenti, onorate questo giorno; voi che avete digiunato e voi altri che non avete digiunato, oggi siete nella gioia. La tavola è colma di cibi, godetene tutti! Il vitello è grande e nessuno se ne andrà affamato (cf Lc 15,23). Godete tutti della ricchezza della sua bontà. Nessuno si lamenti della sua povertà: si è manifestato il Regno preparato per tutti.
Nessuno pianga per i suoi peccati, perché il perdono si è levato dalla tomba. Nessuno tema la morte, perché la morte del Salvatore ci ha liberati! L’ha resa impotente colui che da essa era tenuto prigioniero. Scendendo negli inferi li ha spogliati, ha amareggiato quegli inferi che avevano gustato la sua carne. Isaia, prevedendolo, aveva gridato: Gli inferi furono amareggiati (Is 14,9). Come ti incontrarono furono amareggiati perché distrutti (cf 1Cor 15,26); amareggiati perché scherniti. Gli inferi avevano accolto un corpo e si sono trovati davanti Dio; avevano accolto la terra e hanno incontrato il cielo; avevano accolto quello che avevano visto e caddero per quello che non avevano visto.
O morte, dov’è il tuo pungiglione? O inferi, dov’è la vostra vittoria? (1Cor 15,55+Os 13,14). Cristo è risorto e voi siete stati precipitati! Cristo è risorto e i demoni sono caduti! Cristo è risorto e gli angeli si rallegrano! Cristo è risorto e non vi è più alcun morto nella tomba (1Cor 15,22). Cristo è risorto dai morti, primizia di quelli che dormono (1Cor 15,20).
A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen”.
È ancora e sempre l’accecante bagliore della carne lacerata e ritta dell’Agnello, a raccontarci che Dio è più grande.
Più grande. Un comparativo senza comparativo, dove confessiamo Colui che abbiamo da ri-conoscere Signore e Salvatore, senza fine e in ogni tempo. Anche in questo tribolatissimo e, per tanti, troppi, tempo dolente e foriero di morte. Colui che si rende noto unicamente e solo attraverso un passo in più: come quel passo in più della pietra pesante ma rotolata, quel passo in più di Maria Maddalena avvinghiata ma inviata, quel passo in più dei discepoli impauriti ma che salgono in Galilea. Il nostro, personale, passo in più che in questo itinerario sanante nella Quaresima e salvifico nella Pasqua di morte e risurrezione, nella forza dello Spirito, chiediamo al Padre di poter decisamente porre.
Più grande delle concezioni e delle esperienze che noi abbiamo di lui. Oltre la sistematica accuratezza delle nostre teologie e la veemenza delle nostre ustionanti passioni. Solo perché più grande, può rivelarsi a noi in ogni istante, senza fine e privo di misura, oltre ogni nostra aspettativa e preventivo. A noi accoglierlo nella sua libertà e liberalità, nella sua radicale alterità di eterno Vivente e di autentico Uomo risorto.
Più grande delle nostre feriali morti. Più grande della nostra ultima morte. Ognuna smaschera che ogni desiderio – dal più santo al più sconcio – è imbrogliato proprio dall’oggetto che, immediatamente, lo soddisfa. Sì, per vivere, sempre, sempre va posto un passo in più. Domiciliamoci, con fede e con amore, nella carne lacerata e ritta dell’Agnello. Nell’accamparci altrove, nel trattenerci lontani, nell’abbarbicarci a noi stessi, una falce ci miete.
Domiciliati nella carne gloriosa del Vivente Signore veniamo “Protecti paschae vespero a devastante angelo, de Pharaonis aspero sumus erepti imperio”: Nella sera di Pasqua, protetti dall’Angelo devastatore, siamo strappati al duro dominio del Faraone!
Tutti e ciascuno possiate gioire della pace del Signore e dello stupore di un cuore nuovo plasmato dallo Spirito Santo, primo agente di ogni santificazione. La Vergine Maria, sollecita nell’ascolto e Madre di misericordia, ci renda veri discepoli del Figlio Gesù e premurosi verso tutti coloro che incrociamo nella vita.
Vi abbraccio fraternamente, invocando la benedizione abbondante del Signore
✠ padre Mauro Maria